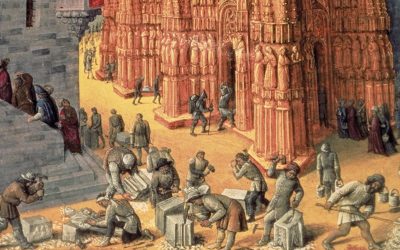di Augusto Vasselli
Sovente si fa, giustamente, riferimento a Dante Alighieri, la cui opera è ancora viva ed attuale, in particolar modo la Commedia, mirabile sintesi poetica, teologica, filosofica e politica, che trasmette messaggi universali, i quali affondano le loro radici nella filosofia perennis, ovvero in quella che oggi chiamiamo Tradizione.
Il sommo poeta nasce a Firenze nel 1265 in un giorno non conosciuto (forse sotto il segno dei gemelli, il che sta a dire tra il 21 maggio e il 21 giugno), da una famiglia della buona borghesia, come potremmo dire oggi, legata ai guelfi bianchi. Perde giovanissimo la madre dopodiché suo padre arriva presto a nuove nozze. Brunetto Latini, che Dante stesso ricorda sempre con un sentito e toccante affetto, forse anche per questa perdita, diviene la guida del Sommo poeta soprattutto riguardo i suoi studi. La sua vita è presto condizionata dalla attiva e forte presenza delle fazioni politiche che dividono, anche a quel tempo, la società civile e il sistema politico, nel quale viene presto coinvolto. Ciò nonostante, quale guelfo bianco, sa tessere buoni rapporti con i Ghibellini e i Guelfi Neri, che gli consentono, nel 1300, di divenire uno dei 6 magistrati anziani, espressione dei guelfi bianchi. La sua brillante ascesa politica è però interrotta da una accusa riguardante una pretesa appropriazione indebita, che lo costringe all’esilio e a subire una condanna in contumacia. Da quel momento inizia la sua vita errante, che vede la sua fine terrena a Ravenna il 14 settembre 1321, ove, negli ultimi anni della sua vita viene accolto sotto la protezione di Guido Novello da Polenta.
Questo in estrema sintesi un breve flash biografico.
Ma la grandezza di Dante, non deriva certamente dal suo cursus honorum e da particolari meriti civili, sociali e politici. La sua grandezza discende dalle sue opere ed in particolare dalla sua somma opera “La Commedia”, che presto viene definita ed aggettivata universalmente “divina”. Un’opera che attraversa i secoli, che ancora parla a coloro che leggono, consentendo a ciascuno di cogliere seppur in parte i molteplici messaggi.
La Commedia, accanto a una erudizione in cui si concentrano tutta la scienza e il pensiero del Medioevo, e nella quale si intravede naturalmente il carattere appassionato dell’Autore, comprensivo anche del suo pronunciato ego, è la narrazione di un erudito, che non manca di descrivere le correnti spirituali del Medioevo che sa cogliere, altresì, la profondità delle cose, della vita umana, dell’universo e della “Saggezza divina”, da grande ricercatore quale era.
In questa opera, che potremmo quasi definire “multilevel”, viene anche descritto quello che può essere considerato il viaggio simbolico interiore dell’Alighieri. Un viaggio che è, sia una narrazione del cammino sia un sottile filo di Arianna, rivolto a chi vuole capire, attraverso i quali viene trasmessa la filosofia perennis, la quale come sempre indica le modalità che ciascuno dovrà poi acquisire e personalizzare, per perfezionare se stesso e ricercare in tal modo la propria realizzazione.
Si tratta pertanto di un’opera che rappresenta un insieme di conoscenze, non limitate al comune sentire, le quali indicano l’esistenza dell’intuizione, presente in noi ma sovente non attivata, riguardante la consapevolezza dell’anima umana, dalla quale si parte per accedere ad un’unione indefinibile tra l’Ente essente e il Tutto (inteso come manifestazione). In altri termini l’opera ricomprende indicazioni, peraltro di una straordinaria bellezza espressiva e semantica, volte a poter ricercare un cambio di co-scienza (consapevolezza) per il tramite della reintegrazione totale delle potenzialità insite nell’essere umano, attraverso quella che può essere definita una maturazione, ovvero un’alchimia che può far cambiare la visione prospettica di ciò che ci circonda e del nostro sentire. In altri termini un messaggio, nel suo insieme, così variegato ed articolato, che può essere considerato una sorta di catalizzatore, il quale a sua volta può essere di ausilio all’ottenimento di una vera e propria trasmutazione del nostro essere interiore, anche grazie a questo viaggio simbolico, che Dante ci descrive.
Un viaggio che inizia mediante le cantiche “infernali”, che passa poi attraverso la purificazione del Purgatorio (nomen omen), e che giunge infine alla catartica “Liberazione”, propria dell’eroe che sa arrivare al centro del labirinto, che lo porta verso il suo sé superiore. Naturalmente allorché si sia seguita e attivata l’esortazione di Dante, presente nell’opera stessa, mediante la quale suggerisce al lettore, sia nell’Inferno (IX, vv. 61-63) con i celeberrimi versi “O voi ch’avete li ’ntelletti sani, mirate la dottrina che s’asconde sotto ’l velame de li versi strani” e sia nel Purgatorio (VIII, vv. 19-21) allorché ribadisce: “Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero, ché ’l velo ora è ben tanto sottile, certo che ’l trapassar dentro è leggero”.
La Divina Commedia può essere pertanto considerata un’opera alchemica, un percorso iniziatico, fatto sotto la guida di uno psicopompo, il maestro Virgilio, nell’occasione appunto guida di Dante, il quale simboleggia la vera ragione umana (descritta mediante una lirica intesa in senso antico, mitico e religioso), ovvero l’iniziazione tradizionale, che porta a comprendere la lingua dei cieli, ovvero degli dei, partendo dalla ragione, ma che per dischiudere le porte del Paradiso, necessita di quella che comunemente viene chiamata fede, che in altri termini è il sentire non condizionato, ovvero l’intuizione.
Non a caso Beatrice (emblema della beatitudine e della fede) viene rappresentata come una sorta di intermediario tra Virgilio (discesa agli inferi e purgatorio, rispettivamente opera al nero e opera al bianco) e la Vergine Maria (la quintessenza) che schiude le porte del Paradiso, simbolo dell’autentica Religione (opera al rosso), ovvero dell’Empireo, la cui etimologia ci ricorda appunto il fuoco (in greco pyr, πῦρ), raggiunto grazie anche all’ausilio di San Bernardo, il quale che rappresenta la fede e la gnosi e autore tra l’altro della regola dei Templari.
Beatrice ed a un livello superiore la Vergine rappresentano l’elemento femmineo della natura, la chiesa segreta di cui parlavano i catari, grazie alla quale è possibile uscire dalla selva oscura. Cosa che Dante sa poi fare in quanto frequentatore e conoscitore di movimenti diversi; egli fu a suo modo un rivoluzionario anarchico, un soggetto vicino all’Ordine del Tempio, un tomista seguace di San Tommaso, un simpatizzante dei sufi e uno studioso della tradizione cabalistica, nonché un appartenente ai Fedeli d’Amore, i quali sono certamente da considerarsi tra gli antesignani dei Rosacroce.
Allo stesso tempo, Dante è anche cattolico e cataro per quanto questo possa essere paradossale e formalmente antitetico, ma tanto da farlo arrivare a capire che entrambe le dottrine possono dire la stessa cosa, seppur mediante modalità apparentemente opposte o addirittura inconciliabili, che guarda caso sono basate sull’armonia degli opposti. Dante è pertanto consapevole del “nulla sostanziale” della razionalità, che rispetto all’assoluto equivale a una meccanicistica e superficiale rappresentazione della realtà.
Realtà che Dante porta alla luce e sintetizza mediante i principi e con il portato della filosofia perennis, che nella Sua opera, seppur velati, sono palesi. Basti pensare al simbolismo dei tre mondi, espresso per il tramite della partizione in tre cantiche; la discesa agli inferi, ovvero nella intimità del nostro essere, che porta poi all’ascensione finale, grazie a “l’amor che move ‘l sole e l’altre stelle”.
Versi meravigliosi con il quale conclude il suo viaggio descritto attraverso quattro linguaggi (livelli). Quattro, proprio come i tradizionali quattro elementi (terra, acqua, aria e fuoco), ove il primo è riferito all’aspetto letterale, il secondo a quello metaforico-allegorico, il terzo al senso anagogico (che unifica i due livelli precedenti) e infine il quarto, che schiude le porte dell’esperienza “mistica”, alla quale non si accede con il comune pensiero e con la parola comunemente intesa, ma con il “verbo” e attraverso il contatto del nostro profondo con il Tutto.