di Shabbat Menkaura
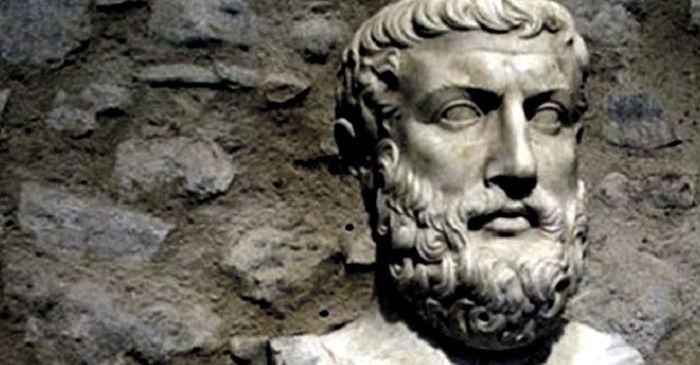
(Parmenide)
Qualche tempo fa fui (indegnamente) invitato da una piattaforma web anglo-americana legata alla massoneria inglese a presentare la mia visione degli studi metafisici.
Questi brevi appunti rappresentano il frutto di alcune delle ricerche che sto intraprendendo per meglio esporre uno dei punti fondamentali delle mie teorie e cioè l’inutilità della (falsa) contrapposizione tra pensiero razionale e metafisico, un contrasto che ha amaramente travagliato il mondo occidentale post-rinascimentale e che ha assunto particolare virulenza dalla fine del XIX secolo sino ai giorni nostri.
A ben vedere, molte delle deficienze della società occidentale contemporanea derivano dalla svalutazione della sua eredità giudaico-cristiana e, più in generale, della feroce critica ad ogni forma di spiritualità tradizionale, che pure tanti frutti ci ha regalato in ogni campo dello scibile.
Per dare manforte alle mie convinzioni di fronte alla mia futura platea ho pensato ad un excursus che, partendo dalle mie terre cilentane, patria di Parmenide e Zenone, circostanza questa che mi offrirà il destro per analizzare il concetto di Ἀνάγκη (Anánkē), farà tappa nella bella Andalusia, o Sefarad come la chiamavano i protagonisti della diaspora ebraica dalla Spagna, per terminare nella mistica Tzfat, ove nacque la moderna Kabbalah.
Come è noto a quei pochi che mi conoscono, sostengo da sempre un approccio olistico al problema epistemologico, in pieno stile rinascimentale e soprattutto un approccio non ipocrita a tale argomento. Se accettiamo, anche con valore giudiziario, la doxa (opinione) di uno psicologo, che epistème non è, non dovremmo poi tacciare di cialtroneria e credulità coloro i quali si occupino, ad esempio, di Kabbalah, perché quest’ultima rappresenta sicuramente il retroterra culturale da cui attinsero sia Freud che Jung.
Infatti, se risulta vero che sia Platone che Aristotele considerarono l’epistème una forma di conoscenza più certa e più vera, se contrapposta all’opinione (doxa), è altrettanto vero che lo stesso Aristotele distinse due percorsi conoscitivi: al livello più alto l’intuizione (simile alla Chokhmah della Kabbalah) capace di “astrarre” l’universale dalle realtà empiriche e che risulta superiore alla semplice deduzione (Binah), che si ha quando l’intelletto umano si limita a recepire le relazioni intercorrenti tra le impressioni sensoriali derivanti dagli oggetti. Per il filosofo di Stagira, quindi, l’intuizione svolge un ruolo attivo che consente all’essere umano di superare le particolarità transitorie dei fenomeni e di coglierne l’essenza in atto, il loro carattere eterno ed immutabile sul piano ontologico, cioè il Reale in senso Parmenideo.
Si potrebbe quasi dire che l’intuizione, come la intendeva Aristotele, getti un ponte tra il pensiero del grande filosofo ed il campo noumenico, cioè verso il platonismo, ad ulteriore conferma che la contrapposizione tra i due grandi filosofi è stata certamente esacerbata da un equivoco riguardo alla reale consistenza della produzione dello Stagirita[1].
Premesso ciò, il contenuto di questi appunti rappresentano la parte centrale dello svolgimento della futura conferenza.
Nell’eterno dibattito tra approccio razionale e slancio intuivo, che in passato era incontro ed oggidì, per la malizia di alcuni è divenuto scontro, si situa un evento prodigioso e stupefacente, cioè il colloquio tra due grandissimi personaggi, fondamentali nella storia del pensiero umano: Abū al-Walīd Muḥammad ibn ʾAḥmad ibn Rušd (meglio noto in occidente con il nome di Averroè) e Muhammad ibn ʿAlī ibn Muhammad ibn al-ʿArabī.
Vorrei spendere pagine e pagine per cercare di far capire ai miei lettori l’importanza di questo incontro, poco meno significativo del fantastico racconto di un memorabile dialogo tra gli stessi due giganti del pensiero greco.
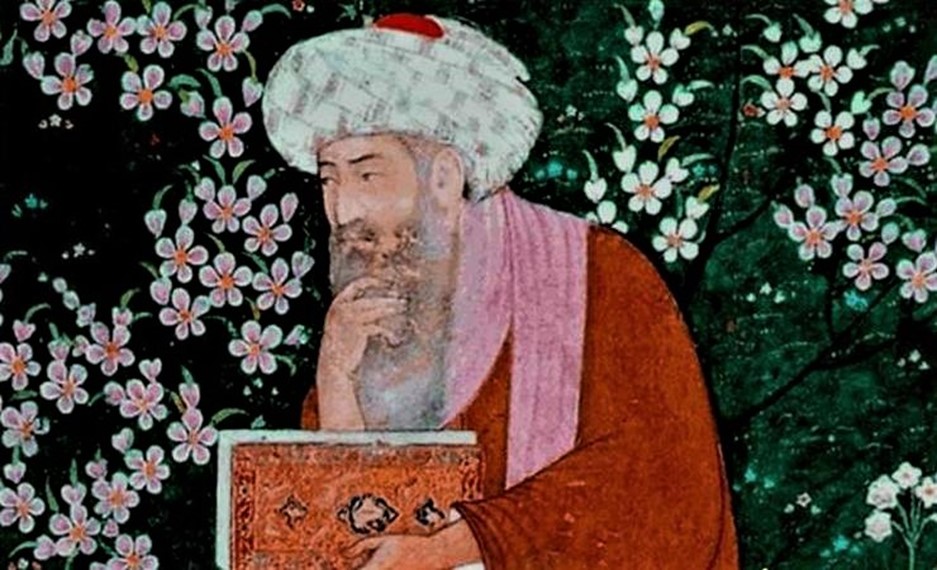
(Muhammad Ibn al-Arabi)
Ma in questo tempo di follia e idiozia non ho più tempo né voglia di spendere molteplici sforzi per convincere gli scettici (Gorgia mi perdonerà per il paragone indegno con i contemporanei) dell’importanza della tradizione … basti dire che ai commentari di Averroè sulle opere di Aristotele, all’epoca quasi completamente dimenticate dal mondo occidentale, dobbiamo il recupero della tradizione del filosofo stagirita in Europa e che Ibn al-Arabi è stato fra i primi pensatori ad esporre una definizione panenteistica di D-o, grazie alla sua famosissima teoria della Waḥdat al-Wujūd (Unicità dell’Essere).
Ed è per tale motivo che sarà mio privilegio, con queste brevi note, condurvi per mano in un viaggio nel tempo e nello spazio verso il cuore della mitica Sefarad, nel crogiuolo tra Ebraismo, Cristianesimo e Islam, ove gran parte di questi temi prese forma e precisamente nella bellissima Cordoba.

(La Mezquita di Cordoba)
Cordoba fu fondata in epoca romana nel 152 a.C., poi conquistata dai musulmani nel 711 e divenne la sede dei governatori dell’Andalusia per quasi tre secoli a partire dal 756, quando fu dichiarata capitale da Saqr Quraish Abdurrahman Addakhil, che la trasformò in una culla della scienza, della cultura, delle arti e della letteratura. La città conservò tali caratteristiche fino alla caduta del califfato omayyade nel 1013, quando i soldati berberi si ribellarono al califfo e distrussero i suoi palazzi e demolirono i suoi monumenti
Dopo la caduta della dinastia omayyade la città visse varie vicissitudini, compresa una devastazione molto intensa e Siviglia la soppiantò come principale centro andaluso. Tuttavia, Cordoba conservò una posizione di grande rilievo e fu in grado di mantenere parte della sua grandezza fino a quando non fu conquistata da Fernando III nel 1236. A causa di questo evento la città fu gradualmente abbandonata e gran parte della popolazione musulmana fu costretta a partire e fu sostituita con altri abitanti di fede cristiana; simbolo di ciò fu la trasformazione della Grande Moschea, gioiello del mondo musulmano, in una chiesa.
Cordoba fu anche il luogo d’origine, se non di nascita, del grande kabbalista Moses ben Jacob Cordovero (1522–1570), il Ramak, autore di numerose opere fondamentali per lo sviluppo dell’esegesi kabbalistica, in particolare del Pardes Rimonim (Giardino di Melograni) — il suo primo libro, una sintesi enciclopedica delle principali tendenze del pensiero Kabbalistico del tempo dotato di molti diagrammi illustrativi, opera che gli assicurò la reputazione di genio del misticismo ebraico.
Una delle figure più importanti di Cordoba fu Ibn Hazm al-Dhaheri, l’autore del trattato noto come al-Muhalla[2], più volte menzionato da Ibn al-Arabi, che pure negò di avere subito alcuna influenza dall’opera di questo pensatore. Tra gli altri famosi poeti e studiosi di Cordoba indubbiamente si distinse Walid Mohammed Ibn Ahmed Ibn Rushd al-Qurtubi, o più semplicemente Ibn Rushd o Averroè il grande filosofo, giudice e leader dei giuristi in Andalusia e Maghreb, che ebbe un grande impatto nella rinascita dell’Europa e che incontrò Ibn al-Arabi quando quest’ultimo era ancora molto giovane, come vedremo a breve.

(Ibn Rushd – Averroè)
Averroè ebbe un profondo impatto sulla storia islamica e non solo e si distinse come brillante linguista e filosofo, personalmente molto umile, ma dotato di argomenti forti ed assiomi incrollabili. Dalla sua analisi dei testi di Aristotele egli trasse lo spunto per riconciliare la filosofia con la legge islamica, correggendo la dottrina delle contraddizioni introdotte dai teologi.
Quando Averroè sentì parlare del giovane Muhammad Ibn al-Arabi e della grande conoscenza mistica a lui rivelata durante la meditazione, si inquietò molto e chiese al padre di Muhammad, Ali Ibn al-Arabi suo amico intimo, di mandarlo da lui per porgli delle domande sulle sue intuizioni metafisiche. Poiché Ibn al-Arabi all’epoca si era isolato dalla comunità dei sapienti e non aveva alcuna intenzione di cimentarsi in alcun dibattito dottrinale, o filosofico, sugli argomenti allora dibattuti tra gli studiosi del tempo, suo padre lo ingannò e organizzò il suo incontro con Ibn Rushd, inviandolo alla casa di quest’ultimo con la scusa di una commissione triviale.[3]
Muhammad Ibn al-Arabi, essendo un ragazzo imberbe, non poteva certo rifiutare la perentoria richiesta di suo padre e sebbene fosse perfettamente in grado di percepire il vero motivo della sua ambasciata nella casa del famoso filosofo, nondimeno ottemperò al suo obbligo.
Quando Muhammad entrò nella stanza dove si trovava Averroè quest’ultimo, che era seduto, si alzò e preso da una sensazione di improvviso amore ed esaltazione alla vista del giovane, lo abbracciò e colmo di emozione gli pose una strana domanda: “Sì?” cui Ibn al-Arabi rispose: “Sì!”.
Questo aumentò ancora la gioia del grande filosofo nel rendersi conto che Muhammad lo aveva compreso, malgrado la laconicità della sua domanda.
Tuttavia, Ibn al-Arabi quando vide la grandissima gioia di Averroè, si affrettò a dirgli “Oh, in nome di D-o, No!”.
A quel punto Averroè fu come colpito da un fulmine ed il suo volto cambiò colore perché in un attimo si trovò a dubitare di tutta la sua conoscenza; quindi, chiese più chiaramente ed in tono più sobrio al giovane: “Come hai trovato la conoscenza della rivelazione divina e della sua effusione?
E questa conoscenza è la stessa su cui noi adoperiamo la nostra considerazione (analisi razionale)?”
Allora il giovane Muhammad rispose: “Sì … No, e tra “Sì” e “No” gli spiriti volano via dalla loro materia ed i colli (cioè le teste, la razionalità) dai loro corpi”.
Rendendosi conto di ciò a cui Muhammad aveva appena fatto allusione, Averroè si sedette di nuovo ed iniziò a mormorare la Ḥawqala[4] mentre il suo volto impallidiva ulteriormente.
Non sappiamo esattamente quando ebbe luogo questo incontro tra Ibn al-Arabi e Ibn Rushd, ma molto probabilmente fu durante l’anno 1184 o poco dopo, perché esso deve essere avvenuto dopo che il primo avesse già abbracciato la Via del Sufismo.
Ibn al-Arabi afferma che Ibn Rushd chiese al padre del mistico di organizzare un altro incontro per discutere se la sua filosofia aristotelica fosse in accordo o in contraddizione con la dottrina della rivelazione interiore propugnata dal giovane Muhammad.
Ovviamente il grande commentatore di Aristotele era portatore di un approccio totalmente diverso, in quanto risultato del pensiero razionale e della deduzione mentale, mentre Ibn al-Arabi non era né un pensatore né un filosofo.
Tuttavia, la fonte è sempre al-Arabi, Ibn Rushd si sentì comunque grato a D-o di essere stato così fortunato da essere personalmente testimone della Divina Rivelazione, cioè della possibilità di entrare in meditazione completamente ignoranti su di un dato soggetto teologico o filosofico e riuscire ad ottenere una conoscenza attraverso la connessione con il Divino.
Si dice che Averroè, a questo proposito, abbia affermato: “Questo è un caso di cui abbiamo verificato l’esistenza ma non abbiamo ancora visto i suoi padroni (cioè non ne abbiamo compreso i meccanismi), grazie a D-o che ho vissuto nello stesso tempo di uno dei maestri che sono stati in grado di aprire le Sue porte chiuse; ringrazio D-o che mi ha onorato di vederlo.”
Ibn al-Arabi riporta che avrebbe desiderato incontrare di nuovo Ibn Rushd, ma fu trattenuto da una visione che gli mostrò la presenza di un sottile velo tra loro due, per cui egli poteva vedere Averroè, ma quest’ultimo non poteva vedere Muhammad e da tale visione il mistico comprese che questo secondo incontro non si sarebbe verificato.
Simbolicamente la visione indicava che Averroè era troppo immerso nelle sue teorie e quindi non aveva alcuna possibilità di percorrere la Via dei Sufi e anche questa risulta essere una considerazione molto profonda sul rapporto tra percorso razionale ed intuizione.
Pochi anni dopo, Ibn Rushd morì a Marrakech e il suo corpo fu trasferito a Cordoba per essere lì sepolto.
Potremmo forse affermare che, come nel paradosso di Zenone di Elea, Ibn al-Arabi avesse intuito che Achille e la Tartaruga, simbolicamente rappresentanti le due forme di conoscenza, empirica ed intuitiva, non potevano avere che un solo punto d’incontro, cioè quello della origine/ritorno dalla/alla unica fonte cioè D-o.
Di qui l’inutilità di un secondo incontro.
Nondimeno la circostanza che detta Fonte divina possa essere raggiunta seguendo alternativamente entrambe le vie è ben presente anche nella tradizione Cristiana, come ben dimostra l’affermazione millenaria nella nostra cultura sia del pensiero Agostiniano, che di quello appartenente ad un altro aristotelico quale San Tommaso d’Aquino.
Vorrei anche sottolineare come il misterioso scambio di poche parole e gesti tra questi due pilastri del pensiero islamico, un sufi e un filosofo, rappresenti un tentativo di esprimere in linguaggio simbolico ciò che risulta molto difficile da spiegare esplicitamente.
Ibn al-Arabi allude ad una realizzazione essenziale che va oltre la normale comprensione umana, il che rappresenta qualcosa che va apparentemente contro la nostra esperienza quotidiana, o comunque si pone come un’esperienza molto difficile da credere.
D’altra parte, ci si sta riferendo ad un concetto che può essere riassunto in definitiva in sole due parole: “Sì” e “No”. A ben guardare anche il “Sì” da solo potrebbe essere sufficiente, perché il “No” rappresenta la negazione del Sì, cioè possiede la natura di “non Sì”[5].
In effetti, questa risposta binaria quasi digitale ante-litteram di Ibn al-Arabi che può essere letta come: “Sì / No”, “1/0”, “Vero / Falso”, o meglio ed in ultima analisi come: esistenza/non esistenza si dimostra l’espressione migliore e più breve della natura omnicomprensiva dell’Essere in senso Parmenideo e della sua irraggiungibilità ed incomprensibilità con i mezzi conoscitivi ordinari destinati all’osservazione degli oggetti.
La difficoltà di esprimere questa Realtà universale in parole semplici deriva dal fatto che viviamo in un mondo diverso di infinita molteplicità, mentre allo stesso tempo la realtà dietro questo mondo è letteralmente troppo semplice per essere creduta.
A titolo informativo vorrei fare cenno al fatto che, curiosamente, la fisica teorica più avanzata sta rivelando modelli della realtà che sempre di più si avvicinano alle “intuizioni” della Kabbalah o del Sufismo ed alle loro ricostruzioni cosmogoniche di cui quella di Ibn al-Arabi rimane una delle più complesse da decifrare.
Tornando al nostro incontro, per i due protagonisti, entrambi credenti, il Reale ultimo è costituito solo da D-o, e D-o è unicamente Uno, mentre il mondo è apparentemente molteplice; quindi, la sfida metafisica risulta nel tentativo di collegare la molteplicità (immaginaria) del mondo al Reale, mediante l’utilizzo di intermediari invisibili, quali le potenze angeliche, l’influenza esercitata dai corpi celesti etc.
Non è un caso, forse, che il concetto di Ein Sof (origine divina di tutta l’esistenza creata, concetto parallelo all’Ayin, che rappresenta il nulla infinito che tutto precede) sia comparso nella letteratura kabbalistica dopo il 1200 e nella stessa Sefarad ove operavano i due protagonisti di questo famoso scambio di idee.
Molto evidente è la correlazione tra i due concetti: ai fini della creazione il concetto di Ein Sof deriva dall’Ayin (nulla) che si specifica nella precisazione della comprensione, di ciò che in potenza può esser compreso (Yesh).
Siamo agli albori dell’elaborazione di quella complessa teoria cosmogonica che sarà poi completata dal gruppo di Tzfat e che conosciamo sotto il nome di Kabbalah Lurianica; risulta però quantomeno particolare che, nello stesso contesto spazio-temporale sia la mistica ebraica, che quella musulmana, abbiano ricevuto un impulso così rilevante e, soprattutto, convergente.
Si prenda l’esempio di Azriel ben Menahem di Gerona, principale allievo di Isacco il Cieco, tradizionalmente indicato come l’autore del Sefer Bahir[6].
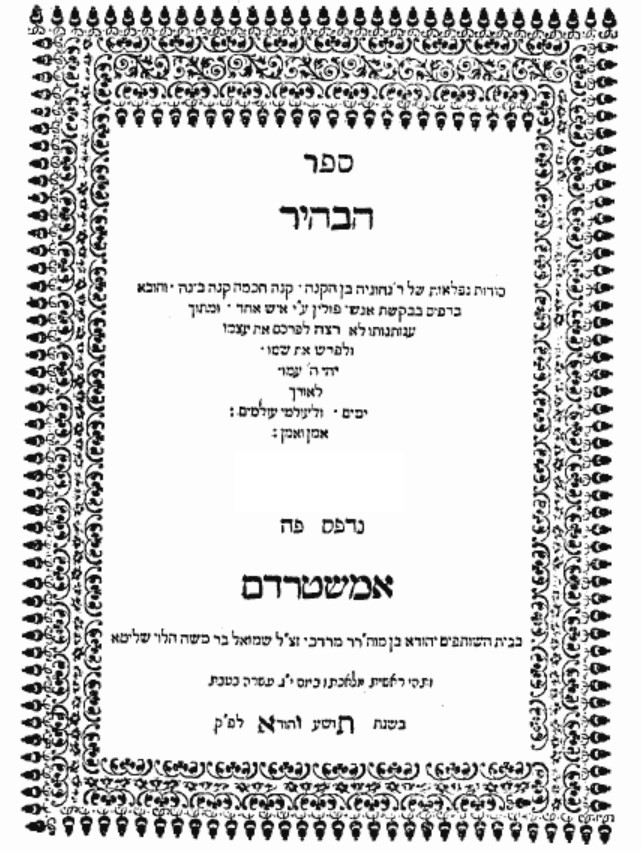
Azriel, confrontandosi con il neoplatonismo, secondo il quale a D-o non potrebbero essere attribuiti desideri, pensieri, parole o azioni, concordava con questa corrente filosofica relativamente alla negazione di qualsiasi attributo divino per l’impossibilità logica di definire un carattere di esistenza relativamente a D-o.
La ragione sta nel fatto che D-o, Essere perfetto, eterno e santo, non può essere suscettibile di cambiamento alcuno, così come stabilito dallo stesso Parmenide.
Infatti, secondo la analisi del Creato operata da questo grande kabbalista, appare chiaro che il concetto di esistenza implichi necessariamente un inizio ed una continuazione, per esprimere la propria funzione o natura. D-o, Causa Prima, ovviamente non può presentare in linea di principio una fine o un inizio.
Filosofi e scienziati in generale, da sempre hanno cercato di comprendere il mondo attraverso le loro osservazioni empiriche, mentre i metodi di Ibn al-Arabi, e degli altri sufi o mistici, si basano su modalità di percezione che si proiettano nell’invisibile per avvicinarsi direttamente al Reale.
In altre parole, lo slancio verso D-o, conseguito soprattutto attraverso la meditazione, consente ai mistici l’acquisizione di verità intuitive, difficilmente trasferibili ad altri, ma non per questo prive di validità o di dignità.
Come sottolinea spesso Ibn al-Arabi, le osservazioni empiriche (quelle della scienza) sono soggette a molti errori, a causa dell’imprecisione degli strumenti impiegati, siano essi sensi umani o attrezzature tecniche, mentre le vere visioni “in contrasto con le nostre interpretazioni a volte problematiche di esse” sono sempre corrette.
D’altra parte, filosofi e scienziati usano la logica e gli esperimenti per dedurre le loro teorie e spiegare le loro osservazioni, mentre i sufi ed i mistici spesso descrivono le loro visioni senza prestare troppa attenzione a spiegarle in modo logico, specialmente quando alcune di tali visioni, sebbene reali e vere in senso metafisico, possano essere in superficie apparentemente illogiche.
In conseguenza di ciò, alcuni sufi come Ibn al-Arabi possono raggiungere uno stato molto elevato di conoscenza della realtà più rapidamente e più accuratamente dei filosofi, ma trovano molto difficile spiegare le loro convinzioni ad altri che non abbiano potuto provare le medesime esperienze per mancanza di un linguaggio comune capace di comunicare questo tipo di percezioni, un po’ come sosteneva Gorgia nella sua critica agli Eleatici.
Quindi, quando i mistici cercano di spiegare le loro intuizioni, non molte persone sono in grado di comprendere quanto viene loro spiegato ed è per questo motivo che apprendere la giusta simbologia attraverso i percorsi tradizionali può risultare di grande aiuto in tale impresa.
In breve, il significato profondo della domanda di Ibn Rushd era che egli stava chiedendo a Ibn al-Arabi se le leggi della fisica e la visione filosofica della natura raggiunta dai saggi, erano coerenti con quanto “appreso” attraverso le vie della rivelazione mistica.
La risposta di Ibn al-Arabi fu “sì” e “no” allo stesso tempo, perché ciò che è vero per il mondo fenomenologico, che osserviamo con i nostri sensi limitati, non deve necessariamente risultare vero relativamente alla Unica Realtà, in quanto il mondo sensibile, se comparato alla Realtà Suprema risulta immaginario.
In altre parole, secondo questa concezione, l’universo (o multiverso) non sarebbe che un artefatto risultante dalla Creazione e che, lasciato al suo destino, non potrebbe persistere per più di un battito di ciglia e per tale ragione necessita di essere continuamente ricreato di nuovo da D-o che in ogni istante sostiene attivamente la Sua creazione.
Questa concezione costituisce una convinzione comune anche tra i più rinomati Kabbalisti (per tutti vedasi Aryeh Kaplan, Paradoxes in The Aryeh Kaplan Reader, Artscroll 1983) i quali specificano ulteriormente che il concetto di tzimtzum, la contrazione dell’Essere Perfetto necessaria per consentire la Creazione secondo le teorie lurianiche, debba includere un inerente paradosso riguardante la contemporanea trascendenza ed immanenza di D-o.
Da un lato, se l’Infinito non si limitasse, allora nulla potrebbe esistere: tutto sarebbe sopraffatto dalla totalità di D-o. L’esistenza richiede quindi la trascendenza di D-o, come sopra descritta. D’altra parte, D-o mantiene continuamente l’esistenza dell’universo creato, e quindi non può assentarsi da esso anche solo per un attimo.
Come ci dimostra l’Alter Rebbe nei due capitoli di apertura della Shaar Hayichud Vehaemunah, la seconda parte del Tanya, la forza vitale divina che porta tutte le creature all’esistenza deve essere costantemente presente in esse… se questa forza vitale abbandonasse qualsiasi essere creato anche solo per un breve momento, questi tornerebbe a uno stato di assoluto nulla, come prima della creazione.
Rabbi Nachman di Breslav nel Likkutei Moharan (I, 64:1) spiega questo paradosso intrinseco come segue: “Solo in futuro sarà possibile comprendere lo Tzimtzum che ha dato vita allo ‘Spazio Vuoto’, perché dobbiamo dire di esso due cose contraddittorie … lo Spazio Vuoto è nato attraverso lo Tzimtzum, dove, per così dire, Egli ha ‘limitato’ la Sua divinità e l’ha ritratta da quello spazio vuoto ed è come se in quel luogo non ci fosse più presenza divina … ma la verità assoluta è che la divinità deve comunque essere presente anche lì, perché certamente nulla può esistere senza che Egli gli dia vita.”
Torniamo per un’ultima volta al colloquio tra i due grandi filosofi. In conseguenza di quanto abbiamo cercato di dimostrare prima, queste parole “Sì/No” apparentemente minano la teoria della causalità ed altre leggi fisiche e cosmologiche.
Ciò è frutto di un paradosso. Infatti, non esistono affatto leggi immutabili, ma esiste una creazione legata solo alla volontà di D-o Onnipotente, che a noi appare come un qualcosa di eterno ed inevitabile.
Le leggi fisiche sono leggi dello stato fenomenologico che possono spiegare il passato, o forse il tempo, ma che non possono fare alcuna previsione di ciò che verrà ad essere, perché il futuro si riferisce solo alla volontà di D-o Onnipotente, anche se solitamente accade che Egli crei le cose secondo le leggi che ha stabilito in natura.
Infine, la nostra percezione della reale struttura dell’Universo è in continuo divenire tanto che le scoperte scientifiche e le teorie che ne sono scaturite negli ultimi trent’anni hanno iniziato ad esplorare ipotesi che possiamo definire senz’altro al confine di quanto oggetto delle visioni degli tzaddikim.
Come abbia già detto e citando un famosissimo film: “alla fine ne rimarrà soltanto uno!”, nel senso che fisica e metafisica saranno riconciliate nella Yichud che è per ora possibile solo per gli Tzaddikim e per le anime dell’Olam HaBa, cioè per i santi ed i defunti.
[1] A causa degli accidenti della storia bisogna sottolineare che di Aristotele conosciamo solamente i trattati del Corpus, cioè le opere sistematiche che lo Stagirita scrisse a scopo didattico, opere definite acroamatiche o esoteriche in quanto destinate agli studenti della sua scuola. In aggiunta a queste Aristotele scrisse anche dei dialoghi destinati al pubblico, che lui stesso chiamò essoterici e di cui ci sono noti solo pochi frammenti. Sempre per un caso le opere pubblicate, scritte durante la permanenza di Aristotele nell’Accademia di Platone, furono dimenticate perché sostitute nella pubblica attenzione dalla pubblicazione dei trattati, avvenuta a Roma nel I sec. a.C. Dei trattati si erano perse le tracce da molto tempo ed il loro ritrovamento fu causa di grande eccitazione, finché Silla con la presa Atene nell’84 a. C. se ne impossessò e li portò a Roma ove vennero riordinati e pubblicati conquistando immediatamente una fama enorme.
Il problema è che è proprio l’Aristotele dei dialoghi giovanili quello conosciuto, amato ed in qualche caso criticato dagli studiosi e dagli altri filosofi, sino al tempo in cui gli scritti didattici divennero assolutamente prevalenti e ciò avvenne solamente in tarda età imperiale. Le opere esoteriche, quelle della maturità sono connotate da un approccio rigorosamente razionalistico e scientifico e furono considerate, da chi ebbe il privilegio di poter consultare sia queste che quelle essoteriche, portatrici di teorie differenti e talvolta opposte con quelle esposte negli scritti essoterici, questi ultimi sicuramente di ispirazione maggiormente platonica. Per tale motivo si affermò incontrastata l’opinione che solo i trattati del Corpus esponessero la vera dottrina aristotelica con il conseguente rifiuto dei dialoghi precedenti, che di lì a poco caddero nell’oblio. Per fare un esempio concreto si prenda la famosa critica che Epicuro fece delle idee dello Stagirita. Come dimostrò Ettore Bignone nel suo “L’Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro” (1936) per Epicuro il “vero” Aristotele era quello delle opere essoteriche ed in particolar modo del Protrettico (o Protreptico o “Esortazione alla filosofia”) scritto da Aristotele intorno al 350 a.C., opera che non è giunta sino a noi, ma che conosciamo dalle numerose citazioni contenute nello scritto portante il medesimo titolo di Giamblico.
Questa opera, che fu allora considerata il manifesto dell’aristotelismo, venne attaccata da Epicuro sulla base delle affermazioni in essa contenute relative all’immortalità e divinità dell’anima, di platonica memoria, e della epistème come reminiscenza. Epicuro riteneva che ciò togliesse valore al conoscere empirico, fenomenico e sensibile; tutte dottrine queste assenti nei trattati, che il filosofo epicureo come tanti altri filosofi e commentatori non ebbero modo di leggere.
[2] Il Kitab al-Muhallā bi’l Athār, noto anche come Al-Muhalla (“Il dolce” o “Il trattato adornato”) è un libro di legge e giurisprudenza islamica. È considerata una delle fonti primarie della scuola zahirita (lett. apparente, manifesta) all’interno dell’Islam sunnita.
[3] La fonte principale su questo incontro è costituita dalla celeberrima opera di Ibn al-Arabi: Al-Futuhat al-Makkiyya “le Rivelazioni Meccane” scritta tra il 1203 ed il 1240 nella quale il pensatore andaluso espose il suo cammino spirituale, la sua teologia, la sua metafisica e il suo misticismo, usando a volte la prosa, a volte la poesia. Il libro contiene elementi autobiografici: incontri, eventi e illuminazioni spirituali. Le Rivelazioni sono suddivise in 37 volumi e 560 capitoli.
Il libro prende il titolo dalla città santa della Mecca, dove Ibn al-Arabi si recò in pellegrinaggio nel 1202, e in cui ricevette una serie di rivelazioni di origine divina.
Nelle Illuminazioni Ibn al-Arabi sviluppa una teoria dell’immaginazione e del mondo immaginario oltre ad una descrizione psicologica e religiosa degli effetti dell’Amore di D-o (sia nel senso soggettivo che oggettivo dell’espressione) un tema molto caro a tutti i sufi ed ai mistici in generale.
L’opera ha sempre destato critiche violentissime da parte di settori del mondo islamico, critiche giunte financo ad incarnare esplicite accuse di eresia sia contro l’autore che contro le sue idee. Oltre a Ibn Taymiyyah, i suoi numerosi critici hanno incluso non solo importantissimi autori classici quali lo storico Ibn Khaldun (m. 1406), o il sufi Shaykh Ahmad Sirhindi (m. 1624), ma anche in epoca moderna molti membri della setta wahhabita dell’Arabia Saudita ed altri revivalisti e modernisti musulmani. La polemica sui suoi insegnamenti divampò di nuovo nel 1979 quando il parlamento egiziano tentò di vietare la ripubblicazione dell’edizione cartacea delle Rivelazioni Meccane. Il tentativo fallì a causa delle fortissime proteste dell’opinione pubblica. Le donne sono presenti in modo prominente nel libro, in particolare nel capitolo 178 sull’amore. Ibn al-Arabi fu iniziato all’esperienza religiosa da una donna di grande spiritualità spirituale chiamata Nizham, una giovane donna iraniana il cui nome significa “Armonia”. Citò con ammirazione le poesie di Rābiʿa al-ʿAdawiyya al-Qaysiyya o semplicemente Rābiʿa al-Baṣrī (Bassora, 713/717 – Bassora, 801), mistica araba musulmana, considerata la più famosa e venerata donna sufi. La profonda influenza che Rabia esercitò sul sufismo le procurò l’appellativo onorifico di “madre del sufismo”. Con il suo sviluppo, il sufismo dette anche alle donne l’opportunità di elevarsi al rango di asceti, dal momento che nella vita spirituale non esiste disuguaglianza alcuna tra i sessi. Per Ibn al-Arabi Rabia di Bassora fu “l’interprete più prestigioso” dell’amore. Ma da un punto di vista spirituale, se non propriamente iniziatico addirittura, fondamentale per Ibn al-Arabi fu l’incontro e la collaborazione con la famosa mistica Fatima bint al-Muthanna, con la quale egli recitò Al Fātiḥah (la prima sura del Corano) e di cui grandemente ammirò il grado di elevazione spirituale.
Le “Rivelazioni Meccane” costituiscono un classico del sufismo, della teologia e della filosofia islamica.
[4] La Ḥawqala è un termine arabo per riassumere la frase lā ḥawla wa-lā quwwata ʾillā bi-llāhi che di solito viene tradotta come “Non c’è potere né forza se non da D-o”.
Questa espressione è solitamente utilizzata dal musulmano quando egli venga colto da una calamità o in una situazione al di fuori del suo controllo, di solito quando sia oppresso o sottoposto forzatamente alla sofferenza.
[5] In pratica la coincidenza di essere e non essere a livello dell’Ein Sof riconcilia anche la fondamentale critica che Gorgia di Leontini rivolse agli Eleatici nella sua perduta opera Sul non essere ovvero sulla natura, riportata ed illustrata da Sesto Empirico nel suo Πρὸς μαθηματικούς (VII, 65 e ss.) quando al paragrafo intitolato περὶ ἀληθείας (sulla verità, ἀ–λήθεια è lo stato del non essere nascosto; lo stato dell’essere evidente) espone i punti salienti del ragionamento del grande filosofo scettico siciliano: “(65) Gorgia da Leontini fu anche lui del gruppo di coloro che escludono una norma assoluta di giudizio; non però per le stesse obiezioni che muoveva Protagora e la sua scuola. Infatti, nel suo libro intitolato Del Non essere o Della natura egli pone tre capisaldi, lʼuno conseguente allʼaltro: 1) nulla esiste; 2) se anche alcunché esiste, non è comprensibile allʼuomo; 3) se pure è comprensibile, è per certo incomunicabile e inspiegabile agli altri.
[65] Γοργίας δὲ ὁ Λεοντῖνος ἐκ τοῦ αὐτοῦ μὲν τάγματος ὑπῆρχε τοῖς ἀνῃρηκόσι τὸ κριτήριον, οὐ κατὰ τὴν ὁμοίαν δὲ ἐπιβολὴν τοῖς περὶ τὸν Πρωταγόραν. ἐν γὰρ τῷ ἐπιγραφομένῳ Περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ Περὶ φύσεως τρία κατὰ τὸ ἑξῆς κεφάλαια κατασκευάζει, ἓν μὲν καὶ πρῶτον ὅτι οὐδὲν ἔστιν, δεύτερον ὅτι εἰ καὶ ἔστιν, ἀκατάληπτον ἀνθρώπῳ, τρίτον ὅτι εἰ καὶ καταληπτόν, ἀλλὰ τοί γε ἀνέξοιστον καὶ ἀνερμήνευτον.
[6] Yitzhak Saggi Nehor (Provenza, 1160 circa – 1235 circa) è stato un mistico e scrittore francese, figlio del famoso talmudista Abraham Ben David. Rinomato cabalista fu da alcuni considerato l’autore del Sefer Bahir, malgrado altri, specialmente Gershom Scholem, abbiano ritenuto l’attribuzione erronea e totalmente infondata. Il Bahir (ritenuto uno dei più importanti testi della Kabbalah classica pre-lurianica assieme al Sefer Yetzirah ed al Sefer Zohar) apparve inizialmente nel Medioevo in Francia, proprio verso il 1200.







